Elisabetta Maiorano, vedova, insegnante di Matematica, la scelta di accettare l’incarico nel carcere minorile di Nisida, l’incontro con la giovane detenuta Almarina, una ragazza dal passato difficile, pesante: pochi, ma essenziali, sono i tratti selezionati da Valeria Parrella, nel suo romanzo Almarina, per costruire uno spaccato di mondo, per suggerire un’idea di vita, per spiegare che bisogna avere un ideale, e tocca a noi nobilitarlo in quest’unica vita che abbiamo, per orientarne il corso: devi puntare il compasso da qualche parte, per capire quanto ampio vuoi disegnare il cerchio. È questione di scelte. Possiamo adagiarci e lamentarci oppure capire che il futuro comincia adesso.
L’analisi esistenziale è una componente rilevante di Almarina, ma quello che emerge è una riflessione sulla scuola e sul senso dell’educazione.
Elisabetta Maiorano è una donna smarrita e nel contatto con i giovani di Nisida recupera lo slancio propulsivo verso la vita. E questo è un aspetto, certo importante, del libro, ma solo relativo.
Il punto nevralgico del racconto di Valeria Parrella sta nell’aver saputo delineare in modo autentico ed efficace, sentito e incisivo, il valore profondo dell’atto di “insegnare”, nel senso etimologico del termine: lasciare un segno, che può salvare, che fa sperare, che cambia le prospettive, che induce a pensare.
Si tratta di un messaggio estremamente significativo in un momento storico come quello attuale in cui la figura dei “maestri” è demonizzata, è svilita in favore di metodologie che ne riducono la funzione a quella di meri coordinatori di dinamiche di apprendimento presunte come semoventi, solo facilitatori, semplificatori. Il “maestro” è oggi ridotto, nell’immaginario collettivo, a una caricatura del suo ruolo – un po’ come il Pangloss di Voltaire – “sfigato” e certamente inferiore, quanto a carica carismatica, rispetto a figure ritenute più incisive, come gli influencer e gli altri divi del web, comunicatori d’effetto.
Un tempo i “maestri” erano rispettati, si teneva conto del senso delle parole: “maestro” deriva dal latino “magister”, colui che vale “magis”, di più, non certo perché sia superiore, ma perché studiando ha acquisito ed è diventato capace di trasmettere quelle chiavi di interpretazione del mondo, altrimenti irraggiungibili. Un onore e una responsabilità.
Il problema ai giorni nostri è serio: nella scuola contemporanea il “maestro” è schiacciato da una burocrazia soverchiante, da norme e circolari ministeriali, frutto di una mania legiferante solo italiana, da diktat pseudopedagogici che impongono metodi “nuovi”, spesso tecnocratici, ludocentrici, e ipocritamente democratici, di cui, per ora, si ignorano gli esiti. E se qualcuno osa dissentire in merito alla loro efficacia – comunque tutta ancora da dimostrare – oppure avanza dubbi, esprime qualche perplessità, è accusato di “vanverismo pedagogico” o di nostalgie gentiliane. E, invece, semplicemente si interroga sugli ingranaggi di un enorme meccanismo che non può fare esclusivamente del “nuovo”, dell’avanguardia didattica, il sinonimo del “buono”, liquidando tout court quello che, invece, della tradizione va, seppure in parte, assunto e custodito. Le nuove didattiche si basano tutte sull’idea del “fare” in sé, (come del resto le recenti politiche rottamatrici), sulla celebrazione dell’attivismo operativo di cui i ragazzi dovrebbero essere assoluti protagonisti e sul conseguente svilimento del tradizionale “fare lezione”: riportando un’esperienza personale, ad esempio, Paolo Fasce scrive: in carriera mi è capitato di avere studenti che mi chiedevano di “fare lezione”. Il motivo era ovvio: così potevano distrarsi, dormire, farsi i fatti loro, mentre nei gruppi di lavoro erano costretti a lavorare. Al di là delle scelte stilistiche fondate sull’uso – se spontaneo o consapevole, non sappiamo – della figura etimologica “gruppo di lavoro/lavorare”, che rende comunque incisiva la volontà da parte dell’autore di sostenere il senso delle nuove procedure di insegnamento, incentrate sull’azione concreta e non sulle “chiacchiere” dei maestri, si tratta di una demonizzazione evidente della tanto aggredita “lezione frontale”, considerata anacronistica e ormai inadeguata alle nuove generazioni, cresciute con i social e abituate alla rapidità delle immagini tipiche della comunicazione del web: insomma gli alunni avrebbero bisogno di “fare”, di essere operativi, non riflessivi.
L’ingenuità di tale impostazione sta nel dato particolare che così facendo i giovani si disabitueranno ad un’attitudine fondamentale a vivere: la capacità di ascolto, di prestare attenzione anche per tempi prolungati. E appunto nella vita questo ha ripercussioni gravissime: molti dei mali attuali – quelli di una società sempre più individualistica, egoistica – risiedono proprio nel nuovo costume diffuso: il deficit di ascolto. Le nuove didattiche costruttivistiche ne sono complici. A nulla vale correggere il problema celebrando formalmente il lavoro cooperativo, l’azione di squadra, il passaggio dal banco all’isola … i ragazzi non ascoltano e non sono messi nelle condizioni per farlo: e così avremo adulti che non sapranno ascoltare nel senso più ampio del termine, non solo non comprenderanno i nuclei fondamentali di un discorso, ma soprattutto non sapranno mettersi nei panni degli altri, “ascoltando” e sentendo” le loro esigenze, i loro punti di vista. Stiamo creando classi di ragazzi aggregati, ma non certo capaci di ascoltare e di comprendere empaticamente gli altri, mere monadi che stanno insieme come un gregge, ciascuna chiusa nel proprio microcosmo “operativo”. Nella scuola costruttivistica quello che conta sono processi, procedure e prodotti finali; mancano solide finalità culturali, restano quelle economiche dell’autoimprenditorialità, dell’imparare a imparare senza fine, per accettare passivamente l’eterna flessibilità di un lavoro precarizzato programmaticamente e svuotato di ogni certezza. Funzionale a questa ideologia risulta quindi il sistema di “istruzione” (dal latino INstruo): termine in cui il prefisso IN evoca l’immagine di un’azione prepotente di costruzione dall’esterno (sistema) verso l’interno (studente ritenuto tabula rasa e perciò un semplice contenitore di nozioni da inserire). Si ha quasi paura di parlare di “educazione”: evocherebbe memorie rétro. E invece esprime il senso più proprio della libertà di apprendimento. Il prefisso E, infatti, di E-ducazione, indica – in opposizione a IN di istruzione – la libera emersione di ciò che è già presente in potenza nell’allievo e che la scuola amorevolmente e maieuticamente lascia che si esprima, si sviluppi.
Ebbene, Valeria Parrella rispetto alle nuove mode didattiche suggerisce un’alternativa di cui bisognerebbe tener conto nelle discussioni pedagogiche.
In un contesto degradato socialmente e culturalmente – un carcere – Elisabetta Maiorano – la protagonista di Almarina – docente di Matematica, non crea “isole” di lavoro – Nisida lo è già abbastanza – né si limita a insegnare il Teorema di Pitagora. Un giorno porta in classe le lettere di Gramsci. Un ragazzo le chiede il motivo, aspettandosi da un’insegnante di matematica ovvie spiegazioni di matematica. Invece la professoressa risponde ai suoi alunni detenuti in carcere: Gramsci era un carcerato, e queste sono le lettere di un carcerato.
A scuola, al di là dei teoremi e delle equazioni c’è l’esperienza umana: l’atto di “ascoltare” il mondo, le ragioni, i sentimenti di un essere umano, imparare a vedere che cosa ci unisce, visto che è così semplice, facile, attaccarsi a ciò che ci divide.
Il tecnicismo didattico (flipped classroom, peer education, cooperative learning…) è un’illusione: perché crescano uomini, donne, persone, ci vuole senso umano. E le prove standardizzate, i test a risposta multipla che stanno invadendo il mondo della scuola e che rincorrono il grande sogno della “valutazione oggettiva”, sono invece solo un amaro inganno sull’esistenza, in cui non esiste mai la risposta univoca e perciò giusta. Scrive la Parrella, infatti, che nella vita …non esiste nessuna preferenza ma solo il grande caso ci sovrasta, e tutto ciò su cui avremo messo una ics si rivelerà sbagliato se saremo tristi, e giusto se saremo felici.
Certo oggi trovare una soluzione a una dimensione complicata come quella della scuola è davvero un rompicapo e – a cominciare dai Ministri che si stanno alternando alla guida di una realtà che sembrano ignorare – nessuno pare all’altezza del compito. Tuttavia impostare la discussione fossilizzandosi solo sui metodi ne impoverisce il senso, soprattutto se si parte da un idealtipo di metodo che, a partire dalla 107/2015, valorizza l’innovazione – secondo l’equazione nuovo=buono – e azzera l’apporto creativo individuale, la libertà sancita dell’articolo 33 della Costituzione e il valore della tradizione non certo considerata in senso assoluto, ma nei suoi aspetti di volta in volta sperimentati come efficaci.
Una scuola che punta solo ai metodi è una scuola senza calibro, espressione di una società senza spessore. Diceva Camus: quando non si ha un carattere bisogna pur darsi un metodo.
Articolo pubblicato sul sito glistatigenerali.com:
https://www.glistatigenerali.com/letteratura_scuola/almarina-il-futuro-comincia-adesso/
Articolo pubblicato sul sito glistatigenerali.com:
https://www.glistatigenerali.com/letteratura_scuola/almarina-il-futuro-comincia-adesso/
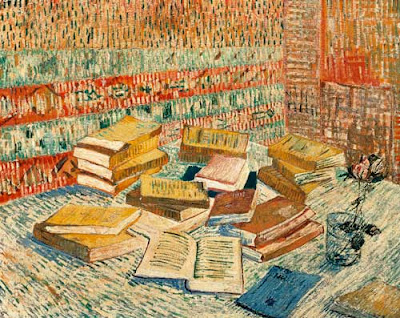

Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.