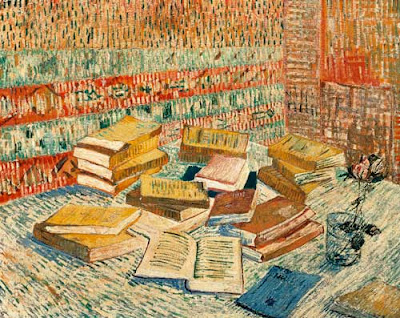La cosa migliore, forse, è non spiegarci,
non dare la chiave del nostro essere,
la formula del nostro destino.
E. M. Cioran, Taccuino di Talamanca
Morfisa o l’acqua che
dorme è un romanzo carico di suggestioni letterarie, di
immagini ad alto tasso simbolico, vi trionfa l’immaginazione sia nella barocca
architettura narrativa sia nel complesso impasto stilistico - abilmente costruito - che varia dalle
sfumature ricercate alla vivacità del dialetto napoletano sino all’uso
insistito dell’ironia da parte della voce narrante che assume nei confronti dei
personaggi una funzione smascherante sullo stile di Cervantes.

La
trama del romanzo di A. Cilento ruota intorno a Teofanès Arghìli, poeta
velleitario capace solo di copiare storie già scritte. Come ambasciatore
dell’impero d’Oriente, egli viene inviato dalle sovrane di Bisanzio, Zoe e
Teodora, a Napoli, dove dovrà prendere in consegna Crisorroè, figlia del Duca
di Napoli, perché la fanciulla possa sposare un Porfirogenito e affinché le
relazioni diplomatiche tra Napoli e Costantinopoli si rinsaldino in virtù di un
matrimonio che è assolutamente un’alleanza politica. A Napoli il messo
d’Oriente scopre che Crisorroè è stata assassinata: alcuni pescatori trovano
tra le reti la sua testa coperta di alghe. Inizia a questo punto per Teofanès una serie di
complicate avventure e di inattesi incontri con creature straordinarie, tra le
quali si distingue Morfisa, la fanciulla polimorfa e metamorfica, che nel
romanzo il lettore conoscerà, infatti, in forma di atleta, aquila, cinghiale,
balena, tra caleidoscopiche trasformazioni, suggerite dal suo nome parlante che
deriva dal greco morphé, cioè, “forma”. Morfisa è la bambina magica venerata
a Napoli come una Madonna, che mette Teofanès, il sedicente poeta, di fronte ai
suoi limiti di scrittore. Grazie ai racconti della fanciulla, infatti, il poeta
scopre quello che gli manca: la creatività, l’immaginazione, la capacità di
donare fascino alle narrazioni, la grazia affabulante della parola.
La
storia si dipana intorno ad alcuni temi focali: il viaggio, Napoli, il mare e
l’acqua, la diversità, il tempo, il fantastico, l’uovo.
Il viaggio, Napoli, la
vita
Morfisa o l’acqua che
dorme è strutturato attorno al più antico archetipo
narrativo, risalente al modello odiassiaco: il viaggio come percorso accidentato e metafora della vita. In questo
romanzo ne è protagonista Teofanès e il suo viaggio assume varie sfumature: è
missione diplomatica, rapimento, prigionia, ricerca. La Cilento, inoltre, aggancia
le suggestioni classiche legate al tema del viaggio a quelle medievali che
attraverso la quête e l’aventure tracciano il percorso lungo il
quale avvengono la formazione e la maturazione dei personaggi.
Napoli,
luogo di approdo per Teofanès, non è solo lo sfondo geografico del romanzo
della Cilento, è, piuttosto, un modo di vedere la realtà.
Napoli
è terra di fede e di superstizione, di devozione e folklore; è la città in cui il
culto di San Gennaro convive con quello pagano di San Virgilio, il poeta dell’Eneide trasformato dalla fantasia
popolare in un mago, profeta, patrono; Napoli, crocevia di culture – greca,
latina, araba, normanna, longobarda – Napoli, carica di fantasia, incline a
colorare di leggenda anche la storia; città fatta di strade, vicoli e piazze in
cui le liturgie delle chiese si mescolano – come attestano le pagine della
Cilento - a riti profani, alle voci dei femminielli, a badesse licenziose, a
prostitute che si concedono, a incesti che si consumano, a stupri che la oltraggiano.
Le
vicende che affronta Teofanès non hanno mai nulla di lineare. Il suo passare da
un’avventura ad un’altra con un ritmo convulso e confuso ricorda il girovagare
del petroniano Encolpio nella labirintica Roma neroniana e sembra imitare la vagatio errabonda del boccacciano
Andreuccio da Perugia che proprio in una
Napoli bella e pericolosa va alla ricerca di se stesso. L’Ulisse omerico
più volte evocato nel testo è, dunque, un modello auspicato da Teofanès, ma non
realizzato: diversamente dall’eroe dell’Odissea, che tornando a Itaca si
riappropria compiutamente dei tutti i suoi statuti identitari di padre, marito
e sovrano, Teofanès appare più come un antieroe, palpabilmente contaminato da
influenze donchisciottesche. Fallire è il suo mestiere: sedicente poeta, è solo
un povero scrittorucolo che sa copiare, ma non ha inventiva; gli viene affidata
una missione importante – trasportare un
utero fresco a Costantinopoli dal Ducato napoletano (p.34) – ma non la conduce
a termine; Teofanès ama Costantino, che improvvisamente a un certo punto del
racconto si fa chiamare Michele, ma quando riesce a possedere davvero il suo
amato, lo perde per sempre. C’è qualcosa di incompiuto in Teofanès. Il suo
smarrimento esistenziale emerge in modo inequivocabile nel ritratto che ne fa
l’autrice nelle pagine conclusive del capitolo relativo alla festa
dell’Oditrigia, in onore di Morfisa, venerata come una Madonna miracolosa: “aiuto” urlò, ma nessuno c’era ad
ascoltarlo. Cercò affannosamente la strada da cui era venuto, fra i cespugli,
non la trovò, si poggiò piangendo a un albero. Ancora si lamentò, ululò alla
luna, e poi, quasi senza accorgersene,
vinto dal vibo, sprofondò nel sonno.(p.92).
Teofanes
cerca: la sua quête (di Crisorroè,
dell’uovo magico che gli fornisca l’ispirazione poetica, dell’amore eterno) è
continuamente frustrata; affronta senza esito esperienze irte di ostacoli e
pericoli, crede nell’amore e resta deluso.
Il
suo labirintico percorso rappresenta
l’esistenza umana: le certezze si sgretolano, le grandi verità vacillano come
gli imperi e si frantumano come la Chiesa aggredita dalle eresie che avanzano.
Perdersi è quasi certo, la vita ha l’aspetto di un locus horridus. Il topos della selva inestricabile in cui Teofanès
si perde e piange, ritorna, infatti, fedele ai modelli tradizionali: Dante,
l’Orlando ariostesco, il Tancredi tassiano smarrito nella selva di Saron. Il
pianto notturno, alla ricerca di speranza e protezione, non può non richiamare
alla mente nel lettore accorto le invocazioni alla luna del Niso virgiliano,
del Medoro di Ariosto, di Lucio nel romanzo di Apuleio, una storia di
metamorfosi, appunto, come quella di Teofanès e Morfisa. La Cilento strizza l’occhio compiaciuto alla letteratura di ogni tempo,
servendosene per costruire un romanzo ingegneristicamente combinatorio.
Kurt Vonnegut iniziava
il suo Mattatoio n.5 con una frase
lapidaria: tutto è accaduto, più o meno.
Il punto è proprio questo: tutto è
accaduto. Il panorama letterario vive oggi in una condizione di estrema
saturazione. Tutto è già stato detto e la scelta postmodernistica del gioco
combinatorio e citazionistico diventa quasi obbligata, come insegnano Calvino,
Eco. Per questo il riferimento ad Eraclito è ripreso testualmente: la vita passa e nessuno si bagna due volte
nella stessa acqua, p.88.
La scelta, poi, della
metamorfosi come tema portante del romanzo (non solo Morfisa, infatti, è
personaggio mutante, anche Teofanès ha una natura duplice: da uomo diviene
donna) non può non ricordare il principio ovidiano espresso nelle Metamorfosi: omnia mutantur, nihil interit, espressione chiara del perpetuo
divenire di ogni cosa, dell’instabilità dell’esistenza. Lo smarrimento di
Teofanès nel labirinto napoletano e il suo pianto disperato nella selva dopo la
festa dell’Oditrigia, dovuto anche al mescolarsi vorticoso di riti sacri e
profani, devozione popolare e menadi danzanti, sembra dimostrare che quel mondo
che noi desideriamo come un ordinato kosmos,
di fatto danza sui piedi del caos. Forse, la presunzione logocentrica non ce la
fa a spiegare il mondo e la convinzione che ciò
che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale, è solo stata una
vana illusione, come aveva già dimostrato Nietzsche. Del resto lo ribadisce a chiare lettere Cioran, l'esistenza è indecifrabile: la cosa migliore, forse, è non spiegarci, non dare la chiave del nostro essere, la formula del nostro destino.
E l’ironia scelta dalla
Cilento come veste stilistica del suo libro, svolge appunto la funzione di
forza demistificante. Le certezze si sgretolano, le grandi verità vacillano, i
punti di riferimento crollano. Un personaggio secondario del romanzo pronuncia
in napoletano una frase-chiave: la
verità! Sulo Dio ave la verità! Lo munno è sogno, lo sogno che ognuno sogna… (p.
184). È chiaramente riconoscibile la
citazione dei versi di Sigismondo, protagonista del dramma di Calderón de la
Barca, La vita è sogno, testo che al
di là del suggestivo titolo, porta in scena il senso tragico dell’inafferrabilità
della verità.
Il logos è perdente. La
figura dei filosofi viene, pertanto, variamente ridicolizzata nel romanzo,
proprio per mettere in evidenza l’insufficienza del loro sistema: i filosofi
sono quelli che discutono del sesso degli
angeli (p.81), ossia si perdono in discettazioni su temi vuoti e verità
indimostrabili; il marito di Maria Merenda, ancora un’altra sorella di
Eudochia, è un filosofo, cioè un inetto: è sua moglie, che, infatti, dotata di
senso pratico, si occupa dei contratti,
degli acquisti, delle vendite, (p. 86) ed è sempre Maria Merenda a definire
Pietro Cènnamo, in senso dispregiativo e sarcastico, quel filosofo di mio marito, (p.114).
La diversità
Uno
spazio privilegiato nel romanzo di A. Cilento è occupato dalla diversità.
Teofanes
è omosessuale; ad un certo punto della storia subisce una metamorfosi e diventa
donna; Morfisa è nera, nasce da uno stupro da parte di un arabo ai danni della
madre Eudochia; è disabile, non può camminare: al posto dei piedi ha due
moncherini. Si tratta di una diversità che a ben guardare ha un marchio
femminile: Morfisa istituisce il Ducato delle Femmine; Teofanès solo in un
corpo di donna riesce a giacere con passione e soddisfazione insieme al suo
amato Costantino/Michele.
Parlare
della donna vuol dire indagare antropologicamente la storia. La società è
sempre stata androcratica e il libro lo testimonia, tutti i luoghi del potere
sono controllati da uomini: le corti, gli assedi e le guerre, i monasteri, la
cultura. Morfisa, però, è donna, governa e, novella Sherazade, racconta storie,
ha il potere affabulante della parola e fa miracoli come una santa. Sovverte un
ordine stabilito da secoli. Introduce la diversità nella storia. Infrange il
tabù del silenzio normalmente imposto alle donne, usa magistralmente la parola,
arriva al governo varando come primo atto politico una legge che impedisce il
matrimonio per le donne sotto i sedici anni di età, dona a tutte le fanciulle
del Ducato un libro e due monete d’oro, ordina ai monaci dello scriptorium della città di istruirle. E
sin dall’inizio manifesta il suo programma di vita rivolgendosi a tutte le
donne: fate sogni grandi.
La sua risposta al
fallimento del logos non è quella che
Italo Calvino chiamerebbe la resa al
labirinto – lo smarrimento, cioè, sperimentato da Teofanès – bensì, la
proclamazione del valore del sogno, il grande motore della creazione artistica.
La proposta di Morfisa è un fil rouge
tra Don Chisciotte e il Calvino delle Città
invisibili che invita i lettori a cogliere nel mondo ciò che inferno non è, cioè, a trovare nell’arte e nella bellezza –
che del sogno e della forza immaginativa sono la diretta emanazione – l’alternativa
agli orrori della realtà.
Morfisa,
donna, affabulatrice, tessitrice di racconti - sembra suggerire sapientemente A. Cilento - è la metafora dell’intellettuale
che è sempre un “diverso”, diverge, cioè, dal mainstream, dal sistema, e lo fa inceppare, ne smaschera le falle,
proprio come fa la fanciulla metamorfica quando coraggiosamente si oppone al
padre pubblicamente e ne decreta la fine.
Emerge,
nell’esaltazione del femminile, il bisogno da parte dell’autrice di
sottolineare il valore del pathos – da sempre rappresentato dalla donna –
contro il logos. In una Napoli che celebra la festa dell’Oditrigia, la folla si
contorce, balla, canta: le donne vengono a chiedere figli, le vergini
cercano marito, le coniugate si procurano svago. Agli occhi di Teofanes
tutto sembra strano, fuori dagli schemi: donne in preda all’ebbrezza della
festa gli ricordano la descrizione sallustiana di Sempronia, colta e
consapevole della propria femminilità, capace di osare più di quanto fosse a
Roma concesso alle matrone: psallere et
saltare elegantius quam necesse est probae, (p. 88).
Se
il logos è quello al potere, se il logos è il maschile, bisogna constatare che
è deludente: genera guerra, intrighi di corte, vizio e si sintetizza nella
figura diabolica del Duca Giovanni, prepotente e incestuoso detentore del trono
napoletano e pronto a concedere la mano della figlia Crisorroè a chiunque si
prospetti come possibile alleato in nome della ragion di stato.
Il tempo
Nel
vorticoso intreccio narrativo di ariostesca memoria e utile a evocare la
dimensione labirintica della storia, anche il tempo è una dimensione antirealistica.
Nel
gioco combinatorio della scrittura - magistralmente orchestrato da A. Cilento - i riferimenti riconoscibili non sono solo
classici e italiani. Appare chiaro, infatti che Teofanès è stato costruito - con un accorta tessitura di rimandi - sul
modello inglese di Orlando, il protagonista dell’omonimo romanzo di Virginia
Woolf, non solo perché come Orlando anche Teofanès è di natura ambigua, è uomo
e donna, ma anche perché come il personaggio della Woolf, anche Teofanès
attraversa il tempo. La storia narrata dalla Cilento, infatti, parte mille anni
fa e attraversa cronotopi svariati: il Giappone della Regina Akiko,
Costantinopoli nel 1204, Troyes nel 1176, Napoli nel 1370, Napoli, ancora, nel
1973-1980. Borges, in un racconto intitolato Il giardino dei sentieri che si biforcano, nota che la narrativa si regge su
una rete crescente e vertiginosa di tempi divergenti, convergenti e paralleli.
Questa trama di tempi che s’accostano, si biforcano, si tagliano o s’ignorano
per secoli, comprende tutte le possibilità. La letteratura, pare suggerire
l’autrice, non è il luogo della mimesi del reale, non è la sede del
frazionamento matematico del tempo e della scansione scientifica delle
successioni cronologiche. La letteratura è fatta, per usare ancora
un’espressione cara Borges, di Finzioni.
Il fantastico e l'uovo
La dimensione del fantastico è
preponderante nel romanzo di A. Cilento, che poggia, sì, su basi storiche, peraltro
dettagliatamente ricostruite, ma è un libro che apre scenari fantastici dagli
orizzonti dilatati e perciò sfugge ad ogni etichettatura di genere.
Un romanzo neostorico?
No: monache volanti che spengono un incendio orinando sulle fiamme non
appartengono ad alcuna memoria storica.
Genere fantastico? No: punti
di forza del testo della Cilento sono l’attendibilità di date, dati e nomi
recuperati da fonti storiografiche e la ricostruzione della fase storica relativa
alla autonomia ducale di Napoli.
Morfisa
o l’acqua che dorme
contro ogni forma di zoliano engagement del letterato, dimostra, crocianamente, che raccontare è un
lavoro di invenzione pura, di immaginazione. L’indagine della
realtà è, infatti, oggetto della scienza che deve studiarne le leggi, della
politica che deve trovare i rimedi a ciò che non funziona: l’arte è un’altra
cosa. Secondo Mario Vargas Llosa i romanzi sono fatti di “menzogne” che aiutano
ad affrontare l’esistenza: gli uomini non vivono solo di verità; hanno anche bisogno
delle menzogne: quelle che inventano liberamente (…). La finzione arricchisce
la loro esistenza, la completa. La letteratura amplia la vita umana, nota ancora Vargas Llosa.
Non
si tratta, dunque, di fuggire dal mondo, ma di arricchire la realtà con la
forza del sogno. Lo spiega bene Julio
Cortázar: il fantastico (…) non è una scappatoia, è un contributo a vivere
più profondamente questa realtà.
Morfisa
ne è certa: quando inventavo storie
da bambina era perché avrei voluto camminare e non potevo, essere bella e mi
era negato, avere una madre ma mi era stata strappata. (…) Invece io sognavo di
essere libera, veloce, potente … L’ho sognato con così tanta intensità che una
parte di me lo è diventata (p. 299). È questo il senso della letteratura,
quello che è nascosto nell’uovo di Morfisa, simbolo della creatività.
Teofanès
“legge” nell’uovo milioni di
storie … quelle conosciute, antiche, degli eroi famosi – Ulisse, Ercole,
Edipo, Medea, Didone, Enea - e quelle non ancora scritte (p.170) e
perciò ancora sconosciute a chi vive nella Napoli di mille anni fa. Teofanès
vede una balena saltar fuori dalla onde contenute nell’uovo in cui
vorticano le immagini che daranno vita ai racconti del futuro e riconosce Pinocchio nel
ventre del pescecane, il capitano Achab che insegue Moby Dick, il vecchio
Santiago di Hemingway che, solo su una barca, cerca a tutti i costi di
pescare il gigantesco marlin. L’uovo è l’origine dell’invenzione artistica, che,
però, non bisogna immaginare generata da fonti esterne all'animo umano. L’uovo rappresenta la
forza creativa che ognuno deve trovare prima di tutto in sé. Perciò sbaglia
Teofanès a cercare di rubarlo, di appropriarsene, nella speranza di trovare
l’ispirazione artistica che possa renderlo famoso nei secoli e dare spessore
alla sua esistenza. Il talento non si insegna. Come diceva Orazio nell’Ars
poetica, occorrono ingenium e ars per essere poeti: ars,
studio, esercizio, metodo, ma soprattutto ingenium, talento naturale,
genio creativo. Certo indagare che cosa sia il talento è arduo. Forse Raymond
Carver ne dà un’idea: è un modo di
vedere le cose originale e preciso, l’abilità di trovare il contesto giusto per
esprimerlo, il dono di vedere quello che gli altri non hanno visto, il dono di
vedere quello che tutti hanno visto, ma vederlo in modo più chiaro, da ogni
lato. Esattamente come sa fare Morfisa.
Morfisa o l’acqua che dorme è un’indagine sul senso del
talento artistico.
A. Cilento, secondo un consolidato schema binario,
risalente già alle strutture esopiche del racconto, costruisce attraverso una scrittura che denota una lunga esperienza, due antitetici modelli
narrativi: uno ideale, alto, nobile (Morfisa) e uno reale, perché molto
diffuso, (Teofanès), fatto di racconti che rinviano a sogni già sognati e a
libri già scritti. A quale dei due si assimila l’autrice, abile tessitrice di
illusionismi citazionistici chiaramente riconducibili alla famosa tradizione del Barocco napoletano? Ai lettori…il compito della risposta.