Mark Fisher inizia il suo libro, Realismo capitalista, con un capitolo dal titolo emblematico e
riassuntivo della sua tesi di fondo: È
più facile immaginare la fine del mondo
che la fine del capitalismo.
Di capitalismo la nostra società è intrisa. E il fatto che
il tachteriano modello T.I.N.A. (There Is
No Alternative) sia considerato a tal punto radicato da abbattere ogni
possibilità di immaginare mondi diversi, ha fatto sì che il Capitale sia
diventato sinonimo esclusivo della realtà. Il realismo capitalista è intriso di
luoghi comuni che ne traducono l’immodificabilità: certo, la nostra democrazia non sarà perfetta, ma è meglio di una dittatura
truculenta. E inoculare il germe del male minore genera la pandemia della
rassegnazione all’esistente come unica e sola realtà.
Fisher va oltre: analizza i mali gravi a cui si accompagna
il realismo capitalista. Sono tutti riconoscibilissimi.
a)
Desacralizzazione della cultura, considerata
inutile, perché non produce utili.
b)
Smantellamento delle tutele del diritto del
lavoro.
c)
Inconsapevole cooperazione di ognuno di noi,
voraci consumatori, alla impersonale iperastratta struttura del Capitale.
d)
Crescita esponenziale dei casi di depressione e
ansia; Fisher ne è una vittima (è morto suicida il 14 gennaio 2017, a quarantotto
anni). Il Capitalismo tende a scaricare sui singoli il problema della malattia
(fenomeno della privatizzazione dello
stress), riducendo i sintomi da stress a una questione di emotività
incontrollata, di disagio personale, di problemi chimico-biologici individuali,
alla percezione di sé come falliti e incapaci di inserirsi nella struggle for life, insomma, buoni a
nulla. Invece, osserva Fisher, il dato è lampante: tante persone, anche
giovani, malate e depresse sono un vantaggio enorme per il capitalismo:
atomizza la società (controllare delle monadi isolate è più facile che render
conto a masse organizzate e consapevoli) e crea un mercato enormemente
redditizio per le multinazionali farmaceutiche e i loro prodotti.
e)
Elaborazione ingegneristica di una macchina
“triturauomini” capace di degradare in maniera irrimediabile la dignità umana:
la burocrazia. Verticismo, inefficienza
generalizzata, sclerosi istituzionale sono gli ingredienti di questo
meccanismo che schiaccia i cittadini riducendoli a meri ingranaggi di un
sistema asfissiante e labirintico.
f)
Ideazione e programmazione di un laboratorio in
cui testare le riforme neoliberistiche: una scuola sempre più piegata a
imperativi di mercato, i cosiddetti target da raggiungere. Questo modello di
scuola è così rappresentato da Fisher: un luogo popolato da studenti persi in
un’inerzia edonistica, annoiati e
sempre troppo connessi per poter
prestare attenzione alle lezioni, prede di qualcosa di più che una semplice
demotivazione. I giovani sono affetti da una sempre crescente incapacità di
concentrarsi e focalizzare alcunché, dipendenza da flusso digitale continuo,
stordimento. Non migliore è il ritratto degli insegnanti: intrappolati tra il ruolo di
facilitatori-intrattenitori che assicurino il più alto numero di
promozioni, e quello di disciplinatori
autoritari, nel momento stesso in cui
le strutture disciplinari sono andate in crisi, cosa che, naturalmente,
toglie loro ogni credibilità. Peggio: mentre
le famiglie cedono alle pressioni di un capitalismo che obbliga entrambi i genitori
a lavorare, agli insegnanti viene chiesto di comportarsi come surrogati
dell’istituzione familiare.
g)
Costruzione del nuovo dogma di controllo delle
coscienze: be smart! La nuova pretesa
delle aziende asservite al Capitale è che i lavoratori profondano un impegno
non solo produttivo, ma anche emotivo: ciò che si vuole è un contributo
affettivo che moltiplichi i risultati. Sistemi di valutazione interni ed
esterni monitorano l’efficienza delle prestazioni lavorative. Tuttavia non
sempre tutto si può calcolare: una buona didattica, ad esempio, come si misura?
Insomma, la metastasi burocratica
dello spettro valutativo fagocita gli obiettivi culturali cui la scuola
dovrebbe mirare.
h)
Strettamente connessa al punto precedente è
l’aleggiante presenza di una struttura simbolica supercollettiva da tutti
presupposta e da nessuno conosciuta: il Grande
Altro che non si può incontrare direttamente, inarrivabile come la massima
autorità dell'assurdo caso di Josef K. nel Processo di Kafka. Direttive, norme, leggi farraginose e
volutamente ambigue sono il magma entro il quale le certezze si disperdono e trionfano l'insicurezza, il senso di colpa, la percezione dell'errore perenne e dell'incombente sanzione, al
punto che i soggetti introiettano l’apparato di controllo comportandosi come se
fossero perennemente sotto osservazione. E alla fine ad essere valutata non
sarà la competenza professionale, la bravura, insomma, del lavoratore, ma solo
la sua diligenza burocratica. In assenza di certezze, spesso l’obiettivo a cui
puntano i dirigenti – confusi esattamente come i loro dipendenti – non è tanto
lavorare di più, ma lavorare in maniera più smart.
Chi davvero potrebbe mai essere in grado di definire il Grande Altro? Aziende,
banche, centri finanziari, il centro imprenditoriale degli interessi politici, l’intera macchina governativa:
chi è il Grande Altro? Intuiamo che dietro i grossi interessi che sembrano
guidare le nostre vite ci sia qualcosa, qualcuno, ma definire tale potere
occulto non è impresa possibile. È chiaro che il principio generativo di
questo stato di cose, la massima causa, non è un soggetto, ma una struttura
impersonale: il Capitale.
i)
Accettazione incondizionata di tutto ciò che è
nuovo, conseguente rottamazione del
passato, riduzione della memoria a mero fattore formale. Si pensi alla
proliferazione di rituali dedicati al ricordo celebrativo e commemorativo di
eventi nell’ottica esclusiva della loro commercializzazione. Viene meno completamente il
calibro della sostanzialità storica: si pensi alla Giornate della
memoria oggi spogliata di effettiva consistenza documentaria e ridotta al
fenomeno della pop shoah..
j)
Nascita dell’idea di uno Stato-balia che vive
sulle ceneri dell’idea di democrazia: si tratta di uno Stato che si manifesta
nelle sempre più pressanti funzioni militari e di polizia e nelle sue
pseudosoluzioni assistenziali per cittadini di fatto messi nelle condizioni di
non poter progettare autonomamente la propria vita. Dell’idea di Stato resta
solo il potere di controllo, ma non l’essenza di una democratica
partecipazione, spesso, quest’ultima, ridotta semplicemente alla
disintermediazione tecnologica, mero simulacro di libertà.
Fisher conclude il suo saggio con una
definizione precisa e amara del nostro tempo, la lunga e tenebrosa notte della storia. Tuttavia non chiude il
cuore alla speranza, quella che a lui purtroppo è mancata: opportunità, barlume di
una anche piccola possibile alternativa
politica ed economica, urgenza di ritagliare
un buco nella grigia cortina del presente sono espressioni che suggeriscono
la spinta a una reazione.
Pochi, ma lapidari sono i suggerimenti:
ridurre la burocrazia, restituire garanzie, diritti e dignità al lavoro,
ricostruire nuove forme di lotta e di protesta, erodere dall’interno gli
ingranaggi dell’automonitoraggio e dell’ossessione autovalutativa cioè liberare i servizi pubblici dall’ontologia
aziendale: se nemmeno le aziende
riescono ad essere gestite come aziende, perché mai dovrebbero farlo i pubblici
servizi?
Si tratta di avere a cuore l’umanità. Seneca in
latino diceva: dum inter homines sumus,
colamus humanitatem. Bisogna avere il coraggio di restare umani. E CORaggio
non significa forza, la sua radice etimologica è CUORE. Il compito è sforzarsi
di trovarlo, in un momento in cui il coraggio è confuso con l’audacia, la
competizione, la prepotenza, la sopraffazione, la logica del vincente a tutti i
costi, l’egotica autoaffermazione anche al prezzo della cannibalizzazione del
prossimo.
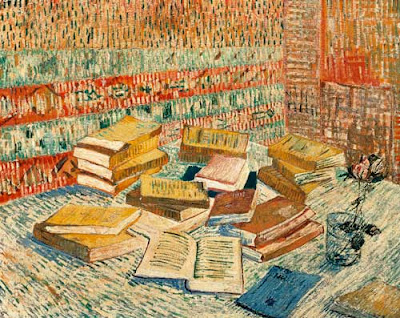

Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.