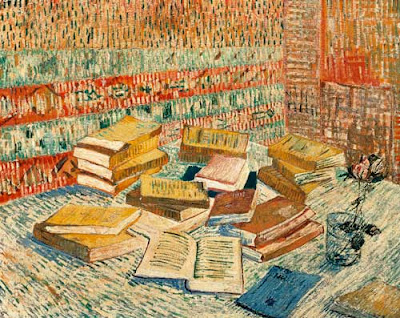Accade spesso che il dibattito sul valore di un libro sia fortemente influenzato da condizionamenti ideologico-politici che privano la discussione di quell’onestà intellettuale, di quella serenità di giudizio necessarie a cogliere del libro il suo significato di fondo e lo spirito che lo anima. Certo, nessuno è completamente immune da personali orientamenti nei criteri di valutazione che adotta, tuttavia sembra opportuno lasciare spazio a letture e a interpretazioni il più possibile obiettive.
“Il danno scolastico” è
uno di quei saggi profondamente divisivi: un forte pregiudizio sul presunto
conservatorismo degli autori ha caratterizzato le recensioni finora pubblicate
(cfr. Vanessa Roghi e Christian Raimo, https://www.minimaetmoralia.it/wp/altro/come-non-conoscere-o-non-capire-nulla-della-scuola-democratica-ovvero-il-danno-che-provocano-le-confuse-opinioni-di-luca-ricolfi-e-paola-mastrocola/
e Vincenzo Sorella, https://www.doppiozero.com/materiali/mastrocola-e-ricolfi-quale-e-il-vero-danno-scolastico).
Si tratta di critiche provenienti da un mondo che si autodefinisce di sinistra, espressione di una pseudosinistra neoliberista che da decenni ha
in effetti snaturato la scuola, allontanandola dalla sua antica vocazione
culturale, per curvarla verso orizzonti sempre più marcatamente aziendalistici
e economicistici di cui, peraltro, viene goffamente mimato il linguaggio.
Da lettrice e docente,
del saggio di Mastrocola e Ricolfi apprezzo la chiarezza espositiva e
l’appassionata difesa di un’idea alta della scuola come ultimo baluardo di
resistenza contro attacchi – ipocritamente chiamati “riforme” - che da anni la
stanno impoverendo e destrutturando. Con una pericolosa operazione di
manipolazione del linguaggio – in atto, a dire il vero, in diversi campi, come
ha recentemente ribadito G. Carofiglio nel suo recente “La nuova manomissione
delle parole” – si dichiara propagandisticamente di voler mettere la scuola “al
centro”, ma nei fatti le si sottrae sempre più calibro, valore, spessore: si riempie
il tempo scolastico di tutto (progetti, gite, orientamenti universitari,
alternanza scuola-lavoro, incontri con esperti di vario genere, test Invalsi),
si svuota la vita scolastica di senso. È chiaramente un disegno preciso: si
chiama “ampliamento dell’offerta formativa”, ma l’unica cosa che si dovrebbe
ampliare – l’orizzonte culturale – resta annebbiato. Non c’è tempo per
imparare. Per ora è così e bisogna ammetterlo, con buona pace dei difensori
della scuola “progressista”, se per progressismo costoro intendono la costante
distrazione da quello che dovrebbe essere l’aspetto prioritario della scuola:
la cultura.
Bisogna essere chiari: la
scuola oggi offre davvero poco. Nel tempo residuale – tra una videoconferenza
con esperti chiamati per fornire delucidazioni sulle possibili scelte
universitarie che il territorio offre, e una videolezione sulla piattaforma per
l’alternanza scuola-lavoro, che riguardo al lavoro non presenta niente e si
riduce a una noiosissima lezione frontale che gli studenti sono costretti a
seguire per mero adempimento burocratico – ebbene, nel tempo che resta, si fa
solo quel che si può: poco.
E se Mastrocola e Ricolfi
denunciano questo deficit di spessore della scuola pubblica, se cioè denunciano
il falso progressismo della scuola pubblica che si è tradotto solo in un
abbassamento vertiginoso dell’offerta culturale, non sbagliano. A ciò si
aggiunga anche la pessima selezione dei docenti, immessi nei ruoli attraverso
concorsi facilitati: si capirà perfettamente che agli studenti lo Stato davvero
non fornisce le lenti necessarie a decodificare il mondo, la realtà, la storia,
la complessità. Ne deriva, ovviamente, che poi abbandonano lo studio, non si
iscrivono all’università. La scuola non li prepara abbastanza. Gli autori del
saggio “Il danno scolastico” questo dicono: la scuola oggi non prepara. È vero,
è sotto gli occhi di tutti, è un dato confermato: all’ultimo concorso in
magistratura (luglio 2021) il 94% dei candidati è stato bocciato
(https://www.ilsussidiario.net/news/magistrati-concorso-flop-94-bocciati-scrivono-male-allarme-servono-800-idonei/2260936/):
gente laureata che ha lacune nell’italiano scritto, nella formulazione scritta
del proprio pensiero, costituisce un risultato allarmante. E non è soltanto
questione di grammatica, è un problema più profondo che investe la capacità di
formularli, i pensieri, di dipanare il groviglio che li intrappola e che impedisce
di tradurli in parole. Un problema serio, non solo linguistico: tredici anni di
scuola e cinque di studi universitari evidentemente non risultano sufficienti a
dotare le persone delle competenze comunicative necessarie a superare un
concorso pubblico.
E quale sarebbe la colpa
di Mastrocola e Ricolfi? Aver denunciato l’ovvio? Deideologizziamo il dibattito
e riconosciamo obiettivamente le falle del sistema scolastico italiano,
ammettiamo la colpa più grave della scuola: aver smesso di insegnare in nome di
un’ipocrita idea di “inclusività” che garantisca a tutti il “successo
formativo”. L’inclusione è un principio sacrosanto (soprattutto se a giovarne
sono tutti gli alunni BES, i più bisognosi di attenzione e cura), giustissimo è
pure l’impegno ad assicurare agli studenti la piena realizzazione di sé, ma tutto
questo non può e non deve essere l’alibi per l’abbassamento degli obiettivi
culturali come quello che oggi i giovani stanno subendo. Lo ha spiegato bene A.
D’Avenia (https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/21_novembre_14/altezza-quadri-bee501f4-458c-11ec-9904-ef3b86729896.shtml):
un buon educatore non appende il quadro all’altezza del bambino – deturpando
una casa – ma lo appende dove è giusto, dove sta bene, e insegna al bambino a
usare la sedia per sollevarsi e guardarlo dal punto di vista più adeguato. E
invece oggi la scuola ha scelto la via più facile, ha abbassato gli obiettivi.
Così, però, non insegna più, tarpa le ali e i sogni. E non è giusto, Don Milani
avrebbe disprezzato questo tipo di scuola che lascia indietro proprio chi
pretenderebbe di includere: se per includere smetto di insegnare, finisco con
l’escludere. Depoliticizziamo l’analisi: chi può davvero dire di essere
soddisfatto da questo sistema di istruzione?
La scuola non riesce più
a insegnare. E le speranze riposte nel digitale, nelle avanguardie didattiche e
nelle seduzioni della gamification si sono rivelate false illusioni, se
non errori: gli studenti saranno anche bravissimi a svolgere un questionario
Kahoot, ma quando scrivono un tema sono in difficoltà. Da anni chi insegna lo
constata. Il cammino è sempre da ricominciare…
P. Mastrocola- L. Ricolfi, "Il danno scolastico. La scuola progressista come macchina della disuguaglianza", La nave di Teseo.