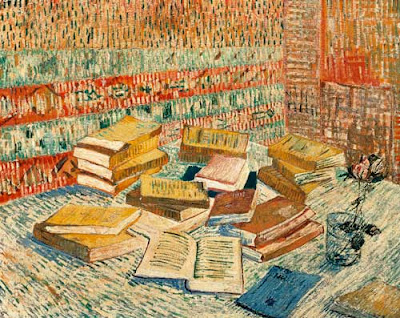Il corpo di una donna è progettato per procreare e dare la vita: ma perché per secoli la biologia ha condizionato le scelte del soggetto femminile relegandolo al solo ruolo di madre? Un figlio è di chi lo mette al mondo o di chi lo ama, lo alleva, lo educa? L’istinto materno è davvero un istinto? Il rifiuto della figura materna è alla base di sofferenze e psicosi che tormentano la vita oppure questo nesso causale è l’ennesimo addebito fatto alle donne da parte di una cultura androcratica capace solo di attribuire responsabilità, oneri, colpe alla figura femminile?
Alessandra Sarchi pone quesiti che mettono in crisi, destrutturano immaginario e tradizione. Il dono di Antonia è la storia di una donna che in gioventù ha donato un ovulo a un’amica californiana per consentirle di realizzare il suo desiderio di maternità. Poi, però, ha troncato ogni rapporto con l’amica, ha avuto paura del suo stesso slancio, della sua generosità.
Ecco, il fulcro del romanzo di Alessandra Sarchi è questo. La riflessione sul senso della maternità è l’espediente, il pretesto narrativo per avviare una seria analisi sul concetto di dono, spingendolo fino all’esame di quello che è più difficile da donare: la vita, l’idea della vita, la possibilità di dare la vita.
Antonia non esita a mostrare il suo affetto a Myrtha: offre il suo ovulo e crede che la felicità dell’amica sia condizione sufficiente per realizzare anche la propria felicità. Poi, a poco a poco cominciano i dubbi, le paure e i tentativi di autoconvincersi che, sì, la generosità è sempre la cosa giusta: si dona il sangue, dunque si può donare anche un ovulo; poi, noi donne di ovuli ne abbiamo tanti…ne doni uno, altri saranno fecondati. Sì, la generosità è la cosa giusta: questo si ripete Antonia. C’è però una domanda fatale, per la quale non esiste risposta immediata: si è sempre all’altezza della propria generosità? Quale prezzo siamo disposti a pagare per quella che consideriamo generosità? È vera generosità quella di Antonia? Il dubbio che la tormenta è proprio questo: a inquinare l’idea di generosità ci sono due fattori. Il primo, umanissimo, è il rimpianto legato al desiderio comprensibile di conoscere poi la vita che crescerà a partire da quell’ovulo donato: per questo Antonia tronca ogni rapporto con Myrtha, per non affrontare la possibilità di voler vedere il bambino che da quell’ovulo donato, nascerà: avevo paura di vederti, di vedere qualcosa che non sarebbe stato mio …Non volevo sciupare il mio dono con la gelosia
Il secondo aspetto che tormenta Antonia è un dubbio atroce, perché sfalda l’idea stessa di generosità: si possono davvero considerare interscambiabili un ovulo e l’idea di vita che porta dentro? Quando Jessie, il giovane uomo che da quell’ovulo ha avuto vita, arriva in Italia e cerca Antonia, lei vive un’epifania, una rivelazione. No, la vita non è interscambiabile, è unica. E in quella unicità c’è un destino, un percorso fatto di scelte, gioie e dolori che ad Antonia non appartengono, ma che la mettono di fronte ai propri errori, alle proprie fragilità. Essere la madre di Anna non compensa l’atto mancato di Antonia che avrebbe potuto essere la madre di Jessie, ma ha scelto di non esserlo. Inizia un percorso di autoindagine, fatto di domande e sensi di colpa che la ragione da sola non dissolve. Il passato lontano, ma mai rimosso, diventa quasi un’ombra persecutoria: è col passato che bisogna aver a che fare, con la memoria custodita e con quella rinnegata.
Sin dall’inizio del romanzo si afferma questa certezza: la cosa sulla quale si ha meno controllo è il passato, e la memoria, e nel passato può esserci tutto.
Sarchi tocca un punto nevralgico del nostro sentirci moralmente nobili: può definirsi generosità il bisogno di misurarsi? Volevo provare a me stessa di valere qualcosa: Antonia dona, ma alla base del suo gesto c’è l’io. È l’esigenza di “centrarsi” a determinare la sua scelta: provavo un sentimento di inappartenenza che tendeva all’ostilità. È la triste consapevolezza di una vita in cui c’era tutto, fuorché un obiettivo a originare la sua decisione. Ma alla fine l’atto di donare non la tranquillizza, anzi dal momento in cui si offre inizia il suo tormento: sentire di aver oltrepassato un limite e non sapere più esattamente quale sia il proprio posto. Ci si può costruire una vita, intorno a una vergogna così.
Il dono di Antonia, forse, allora, non è quello che lei fa a Myrtha. Il vero dono è quello che Antonia riceve da Myrtha. È Myrtha che dona ad Antonia una felicità possibile, la bellezza di essere cercata e amata nonostante le fughe e le chiusure. Myrtha ha pochi anni davanti a sé, è malata, svela a Jessie, il figlio che ha allevato e amato, la verità sulla sua nascita dall’ovulo donato da Antonia. E come in una Telemachia Jessie cerca l’altra madre, Antonia, quella naturale. Il loro incontro è intenso: i due si riconoscono. Jessie non giudica. Madre e figlio parlano, bevono un succo alla menta. Tonano a casa. Un nostos antico.
Il dono di Antonia è quello ricevuto da Myrtha, che ha capito e non ha condannato la fuga della sua amica italiana, ha custodito la felicità che grazie a lei ha raggiunto: e, pensando a Myrtha, Antonia ammette che ancora una volta la sua amica le ha aperto la strada, l’ha messa nelle condizioni di essere una donna diversa.
Il dono di Antonia è quello che riceve da Jessie, che con la sua tenacia nel cercare, con la sua capacità di aprirsi all’ignoto, di rischiare un rifiuto da parte della donna che non ha mai voluto conoscerlo, ha mostrato ad Antonia la parte più bella delle relazioni umane, la fiducia, la capacità di guardare oltre i giudizi e le valutazioni razionali e ha dato spessore – con pochi, ma forti, strumenti, l’ascolto e la parola – a un legame che fino ad ora è stato solo naturale, biologico, di fatto inesistente.
Jessie ora c’è, esiste. Non è più “il passato”. Non c’è molto da ragionare sui “perchè” della vita.
Il dono di Antonia è quello che lei riceve, quando meno se lo aspetta: l’incontro che scompagina gli schemi, la dissoluzione dei sensi di colpa, la liberazione dai segreti opprimenti del passato, la matura comprensione del fatto che quello che ci salva, ogni giorno, sono i sentimenti, non la ragione né la natura. I sentimenti. Quelli che servono a colmare i buchi e la distanza. I sentimenti.
ALESSANDRA SARCHI, IL DONO DI ANTONIA, Einaudi