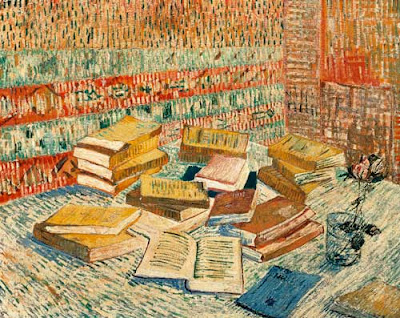La notte ha la mia voce di Alessandra Sarchi è uno di quei libri in cui capisci subito che la dimensione intima e soggettiva è solo una veste, una formula narrativa. Il lettore gradualmente scopre che quella notte, quella voce lo riguardano.
Ci sono due livelli di lettura per entrare nel mondo narrato da A. Sarchi.
Ad un primo approccio si sente la rabbia di chi è costretto a vivere in un corpo traumatizzato: l’io narrante ha perso l’uso delle gambe a causa di un incidente. E il racconto si snoda attraverso l’indagine dei sentimenti di chi deve misurarsi con un mondo che osserva, si commuove, ma che non sa interagire davvero con il dolore, soprattutto quando è degli altri.
E poi c’è un livello metaforico. La paralisi, la sofferenza di arti che non rispondono, la percezione quasi leopardiana che il corpo è tutto, travalicano gli orizzonti pur realistici di sfiancanti percorsi ospedalieri. Non prevale mai nel romanzo l’aspetto cronachistico della ricostruzione fedele di fatti e circostanze che marcano il confine tra i malati e i sani.
La questione che pone questo libro è esistenziale: come fare i conti con la realtà quando questa ti strappa i sogni?
C’è una frase emblematica che sintetizza il punto di vista dell’autrice: l’umanità che si salva, prima di tutto, immagina.
La sofferenza vissuta dalla protagonista è una condizione universale di spossessamento di sé. L’impotenza che si prova di fronte a un mondo che non è più a tua misura, rispetto al quale ti senti sradicato, è un sentimento che ha origini antiche, ma che A. Sarchi tratta in modo toccante.
Viviamo – osserva la scrittrice – in una società in cui tutti usano la bandiera della libertà. Eppure, oggi più che mai, la libertà è solo un’astrazione. La libertà, quella interiore è un concetto bellissimo finché lo incontri nei libri, specie on quelli di filosofia, poi, però, ti rendi conto che la libertà viene sempre da una lotta contro gli altri, contro te stesso, contro gli appetiti e i limiti. I limiti che da ogni parte ti sovrastano. Allora, forse, a pancia piena e desideri saziati, uno può anche dire di sentirsi libero interiormente. Ma, per il resto, di libertà ce n’è sempre poca. E pensaci: tutti rinunciamo alla libertà senza fare troppe storie, quando si tratta di sopravvivere.
Non c’è libertà quando si lotta per sopravvivere.
È davvero libero chi non ha un lavoro?
È davvero libero chi, pur avendo un lavoro, accetta di farsi sfruttare per conservarlo?
È davvero libero chi non si accorge di sacrificare ogni momento della propria vita per un prestazionismo usuraio?
Siamo davvero liberi noi che da decenni abbiamo subito i ricatti di una politica fondata sul modello T.I.N.A (il tachteriano There Is No Alternative) e viviamo ormai curvi su un presente senza orizzonti?
La paralisi del corpo narrata da A. Sarchi è la metafora della malattia di un mondo che ha accettato tutto, più o meno, che ha smesso di sognare.
Nonostante l’ineludibilità del dolore, l’autrice tuttavia nota: se non capisci dove sta il confine tra ciò che è dentro e ciò che è fuori, sarà sempre come scavare nell’acqua.
La notte, allora, ha la NOSTRA voce e perciò sta a noi calcolare le traiettorie della vita, cercare di capire fin dove possiamo spingerci, sperimentando direzioni possibili, immaginando e preservando sempre uno spazio di autenticità vitale, coltivando ciò che è dentro di noi per essere capaci di affrontare ciò che è fuori di noi.
Si tratta di non cedere ai diktat di una sistema che per dominarci ci vuole deboli, fragili, spossati, sfiniti, sopraffatti dalla legge per la sopravvivenza, in uno stato di allerta perenne.
È questo il monito di A. Sarchi: non cedere mai alla tentazione di sprofondare nel nulla: succede dopo i peggiori traumi, la quotidianità riprende e ti ritrovi a vivere, anche se ti senti un alieno a te stesso, costruisci piccole o grandi forme di difesa, abnormità personalissime nelle quali puoi abitare, nelle quali la vita si rigenera.