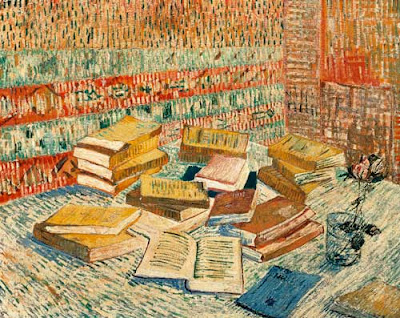Bauman pone in epigrafe al suo
saggio, L’arte della vita, una frase
di Seneca, tratta dal “De vita beata”: tutti
vogliono vivere felici, ma hanno l’occhio confuso quando devono discernere ciò
che rende felice la vita. Seneca sapeva che
rendere felice l’esistenza umana è un’impresa difficile. E oggi non
sembra che le cose siano molto cambiate: questo è il senso del libro di Bauman. Il denaro non dà la
felicità; quello che compriamo nei negozi non dà la felicità; la libertà è
sempre un atto di responsabilità, una costrizione a operare una scelta e scegliere
significa sempre rinunciare a qualcosa: questo non dà la felicità; l’amore e il
desiderio si concentrano sempre su qualcosa che ancora non è, i loro oggetti
sono tutti nel futuro … inaccessibile ai sensi e non indagabile da parte della
ragione.
Va notato, inoltre, che una parte
consistente della nostra vita – e, dunque, della nostra ricerca della felicità
- si svolge nel mondo del lavoro, di cui Bauman fornisce un’analisi amara. L’idea
di dare ordine alla vita, di organizzarla, vuol dire considerare il caos un
male da sconfiggere. Quindi, ogni forma di management orientato al controllo
del disordine è sempre stato considerato un paradigma vincente. Tuttavia la
storia dell’economia sembra dimostrare che il managerialismo è un modello
verticistico che favorisce solo chi è al potere e schiaccia i dipendenti,
trasformando le fabbriche in giganteschi ingranaggi nei quali gli operai sono
ridotti a mere estensioni dei nastri trasportatori. Oggi, in verità, il mondo delle
imprese tende verso organizzazioni che danno più spazio agli aspetti vitali
dell’esperienza, valorizzando l’immediatezza, la soggettività, lo spirito
ludico. Ne derivano apparenti crescite in termini di libertà, creatività, forme
di autogestione e di autoaffermazione nei processi di lavoro, che renderebbero
i dipendenti più autonomi e più soddisfatti nel vedere umanizzata la loro
attività. Va, però, considerato il fatto che nell’era dei telefoni cellulari e
dei computer portatili tale condizione di libertà è solo, come si è detto, apparente:
non ci sono più attenuanti per la propria irreperibilità. Essere costantemente
agli ordini dei propri capi, familiari, amici, non è più solo una possibilità,
ma un dovere, anzi, una spinta interiore.
Si arriva a un paradosso: ora che i dipendenti sono più autonomi e si
autogestiscono, molte aree del loro sé, della loro dimensione privata e
personale, si aprono allo sfruttamento. La nuova organizzazione più democratica
del lavoro, nei fatti è, invece, pronta a divorare tempo, energie, emozioni dei
dipendenti, ai quali si arriva a chiedere -
o, meglio, essi stessi sentono quasi l’obbligo di dare – un’appassionata
dedizione, sollecitata da uno stato di allarme e di emergenza artificialmente
montato per accrescere la performatività di coloro che fanno parte del
sistema-azienda.
Il dipendente ha la percezione
che la strategia delle nuove organizzazioni d’impresa sia il “codice
dell’amore”: non contano più i contratti scritti, ma le continue dimostrazioni
di dedizione assoluta, di abnegazione, utili a meritarsi la simpatia del capo, come
accade in un rapporto in cui ci si adopera per ottenere l’affetto del partner.
Essere amati è qualcosa che non sarà mai confermato a sufficienza. E la
condizione per essere amati è l’offerta costante di prove sempre nuove della
propria capacità di riuscire, di essere sempre un passo avanti, competitivi,
rispetto ai concorrenti anche solo potenziali. E questa è una vita emozionante?
No. È una vita logorante. Sembra davvero una presa in giro il bel parlare di
sinergie e spirito collaborativo. Il codice dell’amore è esclusivista: non si
può collaborare con i/le potenziali amanti del proprio partner! Il mondo del
lavoro oggi è questo: instabilità, sospetto reciproco, ansia.
Può l’essere umano raggiungere la
felicità in queste condizioni?
Secondo Bauman, l’incertezza è
parte strutturale dell’esistenza umana, che non concede nulla senza dura
fatica. E ognuno di noi è disposto allo sforzo incessante pur di costruire la
propria felicità. Ma se la dimensione del lavoro è diventata pervasiva, tanto
da annullare desideri, è ancora possibile immaginare la felicità? Rendere
l’uomo un essere condannato a esistere per la mera sopravvivenza e ridurlo al solo "dum spiro, spero" può davvero bastare? Siamo disposti ad
accontentarci del “finché c’è vita c’è speranza”?
No, l’uomo è fatto per credere
che da un malchiuso portone - direbbe Montale - si possa vedere il giallo dei limoni, si possano sentire
le trombe d’oro della solarità.